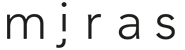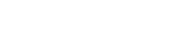Vivian Maier, unseen
“Ho fotografato momenti di intimità perché non andassero perduti”
Un occhio bambino sbuca da una piccola apertura in un cartone per le spedizioni. Da un tronco cavo, tra le rughe legnose brilla curioso un altro occhio infantile. Tra gli incroci di un telaio di una sdraio anni ‘50, un occhietto divertito, quasi impertinente ci guarda. Sono più di duecento gli scatti esposti nella mostra Unseen, allestita nel Belvedere di Villa Reale a Monza, in nove sezioni tematiche.
Appartengono a Vivian Maier, fotografa e bambinaia americana, vissuta tra Francia e Stati Uniti (1926-2009).
La sua storia è ormai nota e si porta dietro quell’alone un po’ misterioso delle scoperte avvenute per caso: quando John Maloof, giovane figlio di un rigattiere, decide, nel 2007, di acquistare in un’asta un box stracolmo di oggetti di tutti i tipi, tra cui una cassa contenente decine di negativi e rullini da sviluppare, inizia la fama post mortem della Maier. Si scopre un mondo, una singolarità, una vita tutta da ricostruire.
Ma tra le numerose e preziose immagini, quegli occhi bambini che ci guardano quasi di nascosto, sembrano raccontare molto di Vivian e di quel suo modo di guardare la realtà. Una riservatezza che è stata la sua cifra, tanto che si dice che nessuno allora si sia accorto di questa sua profonda passione.
È indispensabile stare nell’ombra, non farsi notare, divenire invisibile per sorprendere la verità delle cose. Rimanendo anonimi nella strada, si può allora coglierne l’anima. Lo sguardo a volte scanzonato, curioso, serio e a tratti malinconico è quello di chi si interessa a tutto quello che gli accade intorno e lo fa con estrema gentilezza.
E allora, quando si arriva nei suggestivi spazi del Belvedere allestiti con cura, viene naturale camminare in punta di piedi, avvicinandosi ai volti ritratti, ai luoghi, ai gesti immortalati di un istante, con discrezione, quasi con pudore, lasciando che siano le immagini a parlarci.
Sui muri lasciati spogli, nei loro caldi colori originali, sovrastati dalle gigantesche capriate del Piermarini, tra i tubi in acciaio degli impianti, tra i graffiti lasciati dagli anni passati, giocano con eleganza ed armonia di luci, ombre e colori, le fotografie.
Qui lo spazio si fa cornice e non sovrasta mai le opere, che spiccano come protagoniste indiscusse.
Qua e là grandi bauli aperti, ricoperti di carta da parati in armonia di colori, spezzano gli ampi corridoi creando delle wunderkammer, su cui soffermarsi. Ti invitano a rallentare. A guardare con più attenzione. A prenderti il tempo. Ti interrogano sul perché al loro interno quella foto e non un’altra.
In una stanza più raccolta, intima, sono riuniti i suoi famosi autoritratti. Ogni vetrina, specchio, o riflesso è stata la possibilità per la Maier di immortalare sé stessa. Sembra quasi strano, pensando alla sua vita riservata e misteriosa, che abbia deciso di fermare quei momenti. Al centro di una parete, uno specchio rotondo invita francamente lo spettatore a imitarne il gesto.
In un angolo, dentro uno dei bauli, il cappello e la sua preziosa Rolleiflex sono i segni inconfondibili della sua identità.
Si ha la gradevole impressione di un’essenzialità senza fronzoli mentre si cammina negli spazi allestiti, tra musica jazz di sottofondo, sagome di scorci cittadini, giochi di pareti riflettenti e panchine su cui fermarsi, magari per prendersi il tempo di ripercorrere ciò che si è appena visto.
Si lascia la mostra con la sensazione di aver incontrato soprattutto uno sguardo gentile, capace di osservare il mondo (e noi) con acuta sensibilità.